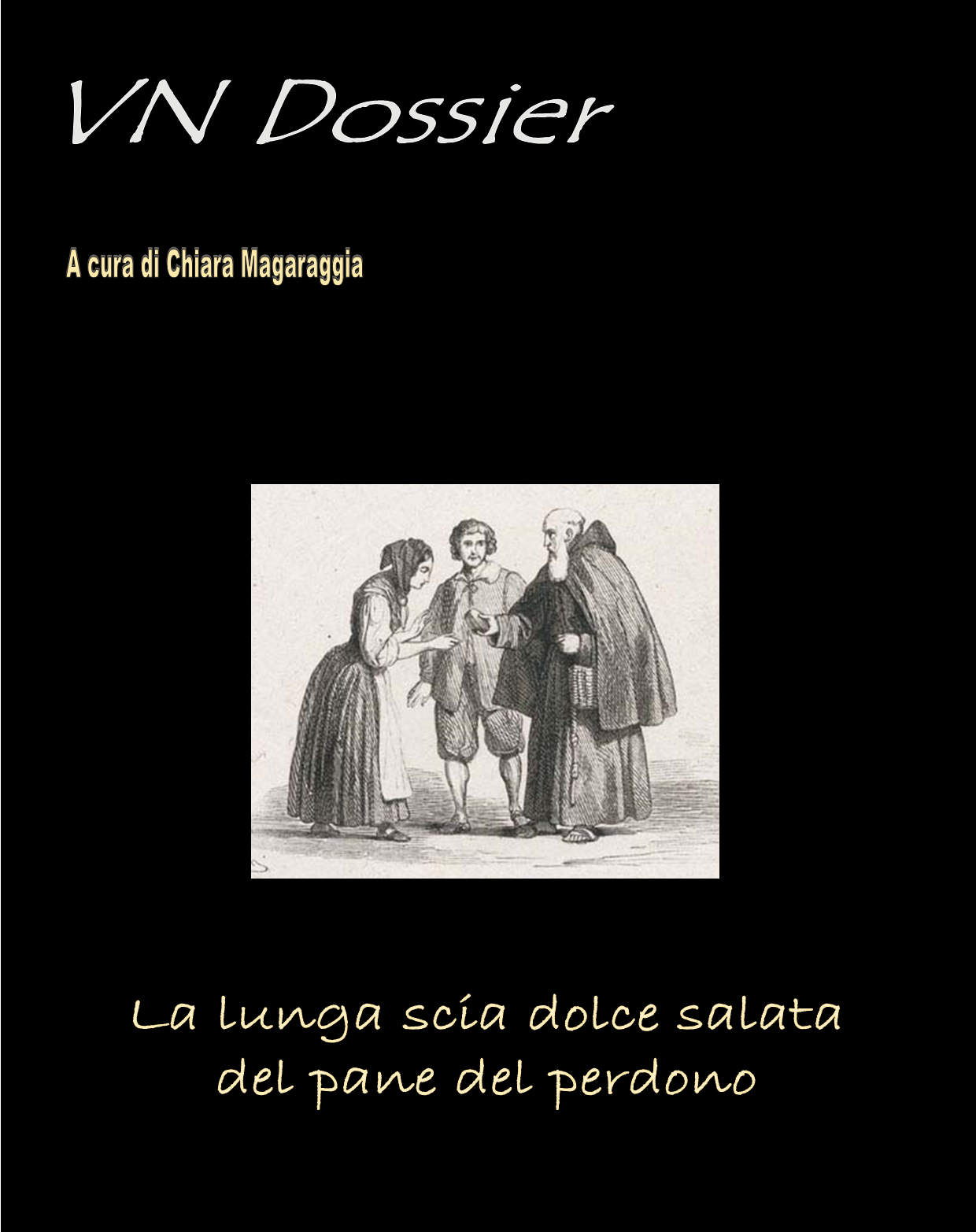Era fiero, generoso e impulsivo, Lodovico, amante della compagnia e amico di tutti, ma non degli arroganti, che godono di umiliare gli altri, soprattutto se deboli e indifesi. Ma sulla sua strada un giorno incontra proprio uno di loro, superbo della sua nobiltà. Provocato, Lodovico reagisce e scoppia una rissa, alla quale prendono parte servitori e scorte dell’uno e dell’altro. Rimedia una ferita ad un braccio ed è a questo punto che, per fargli scudo, il fedele Cristoforo viene trapassato a morte con la spada. Fuori di sé dalla rabbia, Lodovico, a sua volta, sguaina la sua arma e ammazza l’avversario. Scene di quella violenza urbana, che insanguina le città, lasciando scie di dolore, rancore e vendetta. Ma il rimorso del delitto compiuto e il ricordo del gesto d’amore del servitore Cristoforo cambiano profondamente l’animo di Lodovico che, dopo un periodo di riflessione e sofferenza, decide di dare una svolta radicale alla sua vita: diventerà frate cappuccino, assumendo proprio il nome di Cristoforo, per dedicare la sua vita all’espiazione attiva nelle periferie del suo mondo, alla cura degli ultimi degli ultimi. Ma prima vuole saldare i conti con il passato: si umilierà, chiederà il perdono al fratello dell’ucciso. E’ indimenticabile la scena descritta nel 4^ capitolo de “I Promessi Sposi”: il gentiluomo offeso vuole una cerimonia in pompa magna perché – come scrive Manzoni – “quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico: e sarebbe una bella pagina nella storia della famiglia… A mezzogiorno il palazzo brulicava di signori d’ogni età e di ogni sesso: era un rimescolarsi di gran cappe, d’alte penne, di spade pendenti, uno strascico frusciante di arabescati mantelli”. Un autentico movimentato affresco barocco. Sarà per questo che, a fine settembre a Genova, davanti all’opulenza dei velluti, alla teatralità dei gesti e alla straordinaria maestria di resa cangiante dei colori del pittore seicentesco Anton Van Dyck, ai ruoli predestinati del figlio e delle piccole figlie di un Ritratto di famiglia – il giovane militare baldanzoso dalle armi scintillanti, la bambina destinata ad essere sposa dall’abito riccamente decorato e ingioiellato, la piccola che dovrà essere monaca, dal sobrio vestito senza ornamenti – mi si è materializzato davanti agli occhi l’episodio con cui Manzoni sa trasformare una situazione di violenza e di umiliazione in un momento altissimo di perdono e di rigenerazione. Quel fraticello, ferito dentro dalla violenza da lui compiuta più di quanto lo sia, nella sontuosa esteriore messinscena, il fratello dell’ucciso, dirige il suo passo verso il nobiluomo, si inginocchia davanti a lui, incrocia le mani sul petto e, chinando la testa, pronuncia poche sofferte ma ben scandite parole: “Io sono l’omicida di suo fratello. Sa Iddio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue; ma, non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d’accettarle per l’amore di Dio”. Quando fra Cristoforo tacque, s’alzò, per tutta la sala, un mormorio di pietà e di rispetto. La scena raggiunge la massima intensità emotiva nel momento, impensato e incredibile, dell’abbraccio fra i due uomini, carnefice e fratello della vittima, che “gli gettò le braccia al collo e gli diede e ne ricevette il bacio di pace”. Davanti all’insistenza del gentiluomo di accettare qualcosa del ricco rinfresco preparato per rendere più bruciante l’umiliazione, il frate, quasi ritroso, esprime la sua richiesta: “Io sto per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d’aver goduto la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono”. Quel pezzo di pane, “il pane del perdono” rimarrà sempre nella povera bisaccia di fra Cristoforo, con la scia dolce e salata che per tutta la vita marcherà la scelta definitiva. Passano tanti anni e ovunque il frate cappuccino combatte la sua nuova guerra, nei luoghi dove trionfano i soprusi e le miserie, con le armi della fede, della parola, della determinazione. Sempre a fianco di chi ha fame, non solo di pane, ma anche di giustizia. E’ a Milano, quando infuria l’epidemia di peste del 1630. La città è sconvolta, tutte le regole del vivere civile spazzate via, la pietà e la compassione schiacciate dal terrore e dalla paura. Risuonano nelle strade i lamenti dei malati e le bestemmie dei monatti. E’ nella memoria di tutti l’episodio struggente di una mamma ancora giovane “dalla bellezza velata e offuscata ma non guasta” che porta al collo la sua bambina di forse nove anni “morta, ma tutta ben accomodata… con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo. Né la teneva a giacere, ma sorretta, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte”. La mamma sta per consegnare al temuto carro dei monatti, che ogni giorno raccoglie decine, centinaia di morti – una “raccolta indifferenziata porta a porta” di povere creature falciate dalla peste – la sua bambina, Cecilia. Tutta la scena è costruita sulla contrapposizione fra il colore cupo della città appestata che sembra aver oscurato ogni umana sensibilità e il bianco di queste fragili creature femminili, di quelle mani gentili – quelle della madre e quelle della figlioletta – che sembrano essere le uniche ad avere custodito con tenacia i gesti e i valori dell’umanità.
Qualche anno prima della peste manzoniana, Caravaggio in una delle tante fughe che hanno scandito la sua breve vita tormentata, dipinge “Il seppellimento di Santa Lucia”, a Siracusa, proprio nel luogo dove la Santa adolescente ha trovato il martirio. Anche Caravaggio col suo pennello ha dato un volto a tante creature ai margini, a tanti reietti della storia. La sua Lucia è lì, adagiata a terra, una macchia chiara in un fondo scuro, un visetto dolce che riposa tranquillo con gli occhi chiusi illuminati da un trattino chiaro di pennello. Solo una spalla rimane scoperta e il candore della carne evidenzia il piccolo, quasi invisibile taglio sul collo che ha messo fine alla giovanissima esistenza. E anche qui la bianca piccola mano sembra tendere verso noi spettatori il suo ultimo segno di pace. La stessa discreta contagiosa dolcezza di Cecilia e della sua mamma, capace di emozionare e confondere almeno per un attimo sia i carnefici sia i turpi monatti della peste. La disperata contagiosa dolcezza che abbiamo incontrato anche nell’altra Lucia, la giovane popolana che con le sue semplici parole “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia” aveva fatto breccia nella coscienza dell’Innominato. Come in un cerchio magico, tanti destini si incontrano, seguendo l’esile filo della provvidenza che, magari nascosto, sotterraneo e invisibile agli occhi umani, attraversa in modo ininterrotto la storia. Nell’inferno della città appestata, il lazzaretto rappresenta il girone più spaventoso: le piaghe incurabili, la sporcizia, il fumo dei roghi, l’odore nauseabondo, gli escrementi, i pianti, l’abbandono, la morte… tutta l’umana sofferenza sembra radunata nel girone della disperazione. E qui, instancabile fino alla consunzione, opera, ormai vecchio, fra Cristoforo, pronto a soccorrere, consolare, assolvere, chiudere gli occhi agli appestati. E la cosa prodigiosa è che proprio in questo regno dei senza-speranza si concentrano, per opposizione, tutte le opere di misericordia: dar da mangiare, offrire da bere, vestire, alloggiare, visitare, seppellire. Qui finisce anche Lucia, colpita dalla peste, ma ormai guarita… lei esile e sola, mentre il suo potente persecutore, don Rodrigo, sta ormai agonizzando. E qui si ritrovano, dopo tante traversie, tutti i protagonisti. Che strane trame tesse la storia! La peste, che tutto distrugge, senza distinguere fra potenti e deboli, proprio lei, nel più orribile dei luoghi, avvia al lieto fine la vicenda dei due giovani sposi promessi. Renzo ritrova Lucia e ritrova fra Cristoforo, che proprio ai due giovani affida il suo tesoro più prezioso: “Figlioli! Voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò dalla sporta una scatola d’un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappuccinesca; e proseguì: Qui dentro c’è il resto di quel pane… il primo che ho chiesto per carità. Lo lascio a voi altri: serbatelo, fatelo vedere ai vostri figlioli. Verranno in un triste mondo, e in tristi tempi, in mezzo ai superbi e ai provocatori: dite loro che perdonino sempre, sempre! Tutto, tutto! E che preghino, anche loro, per il povero frate”. Il pane del perdono: di bisaccia in bisaccia, dov’è la sua scia dolce salata nei tanti lazzaretti dell’anno del Giubileo della Misericordia? Dov’è nei campi profughi, nella giungla di Calais, lungo i muri e i fili spinati, le barricate di chi non vuole accogliere, nei barconi dei migranti, nel lungomare ferito di Nizza, nelle tendopoli dei terremotati, nelle città bombardate di Aleppo e di Mosul? Eppure… chi salva un uomo salva l’umanità.
A Genova, poco lontano dal grande ritratto di famiglia di Van Dyck, c’è un delizioso quadretto che, nella sua semplicità, sembra suggerirci che attraverso l’arte anche i messaggi più profondi possono diventare “pane per tutti”. L’autore è un pittore fiammingo del Quattrocento, Gérard David e il titolo è particolare: “La Madonna della pappa”, inconsueto quanto
tenero e curioso. Un quadretto che, per le piccole dimensioni e il soggetto familiare, era destinato alla devozione privata delle Fiandre, segno di una religiosità che ormai non è più limitata ai luoghi consacrati – chiese e monasteri – ma che si allarga all’ambito familiare. In braccio alla giovane donna dai capelli biondi e dai tratti longilinei e sottili delle ragazze nordiche, il Bambinello con il cucchiaino maldestramente in mano si protende verso la ciotola, agitando i piedini, irresistibilmente attirato dalla minestrina che la mamma gli sta offrendo. Colpisce l’ambientazione di serena quotidianità arricchita di dettagli della vita domestica: il tavolino intagliato sotto la finestra con il cesto e il libro, la mensola con il vasetto di rose, la finestra aperta su un luminoso paesaggio urbano di verde, d’acqua, di casette dal tetto spiovente di ardesia tipico delle città fiamminghe. E poi c’è il tavolo della pappa, con tre oggetti in primo piano: il pane, la mela leggermente bacata e il coltello. E’ vero, l’eccessiva simbologia può deteriorare la delicata poesia dell’opera d’arte, ma forse siamo proprio noi, oggi, a perderci nell’alfabeto di simboli, che era invece nei secoli passati un linguaggio comprensibile pure per gli illetterati e le cose quotidiane sapevano parlare anche con un linguaggio “altro”: e allora la mela bacata ci riporta alla colpa originale e il pane e il latte della pappa diventano simbolo dell’Eucarestia di Cristo e il coltello ne prefigura la Passione e le rose bianche e rosse sono un omaggio alla Vergine Madre. Ma forse anche quella finestra aperta vuole catturare la nostra attenzione. La pittura fiamminga ha un realismo tutto suo, per cui raramente un paesaggio è frutto della fantasia dell’artista: l’acqua, il verde, le case di Gérard David richiamano in modo preciso il Beghinaggio di Bruges, uno dei luoghi più suggestivi della cittadina belga, dove ha operato l’autore. E il beghinaggio era nel nord Europa un luogo tutto speciale, dove le donne, molte volte colte e di origine borghese, si ritiravano per dedicarsi alla preghiera, allo studio, impastando ogni giorno il pane da distribuire ai bisognosi, inventando meravigliosi merletti e ricami, ancora oggi capaci di incantare. Non pronunciavano nessun voto, non indossavano vesti che le distinguessero, non volevano tutele su di loro. La scrittura delle donne dei beghinaggi (è con una punta di disprezzo che, ancora oggi, vengono chiamate “beghine”) è tra le più originali, libere, sorprendenti e, perciò, spesso bruciate, oscurate, così come alcune delle loro autrici sono state processate e arse sul rogo. Solo da poco questo piccolo tesoro nascosto è oggetto di studio e di divulgazione. Perché non pensare, dunque, che la “Madonna della pappa”, così “femminile” nell’iconografia, non sia stata destinata proprio al Beghinaggio di Bruges?
Esco per i carrugi intricati della vecchia Genova, quelli che portano al Porto Vecchio, splendidamente restaurato da Renzo Piano. Sento uno strano profumo di pane mentre attraverso una minuscola piazzetta intitolata a don Andrea Gallo, il prete di tanti affamati di umanità e percorro via del Campo, dove sembrano risuonare le parole della ballata di Fabrizio De Andrè e dove, da alcuni usci, ancora si affacciano giovanissime prostitute “dagli occhi color di foglia”. Le più famose di queste parole: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori” ornano il piccolo rilievo dedicato al poeta-cantautore. E qui, mentre al tramonto sbuco sul mare, quasi senza accorgermi mi trovo a canticchiare: ”All’ombra dell’ultimo sole/ s’era assopito un pescatore/ e aveva un solco lungo il viso/ come una specie di sorriso.// Venne alla spiaggia un assassino/ due occhi grandi da bambino/ due occhi grandi di paura/ eran gli specchi di un’avventura.// E chiese al vecchio: dammi il pane/ ho poco tempo e troppa fame/ e chiese al vecchio: dammi il vino// ho sete e sono un assassino.// Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno/ non si guardò neppure intorno/ ma versò il vino e spezzò il pane/ per chi diceva: ho sete e ho fame.// E fu il calore di un momento/ poi via di nuovo verso il vento/ davanti agli occhi ancora il sole/ dietro alle spalle un pescatore…// Vennero in sella due gendarmi/ vennero in sella con le armi/ chiesero al vecchio se lì vicino/ fosse passato un assassino.// Ma all’ombra dell’ultimo sole/ s’era assopito il pescatore/ e aveva un solco lungo il viso/ come una specie di sorriso.//. La Lanterna si specchia nelle onde rosso-fuoco del tramonto genovese e sorrido rasserenata: c’è ancora, in qualche bisaccia, il pane del perdono!
Chiara Magaraggia